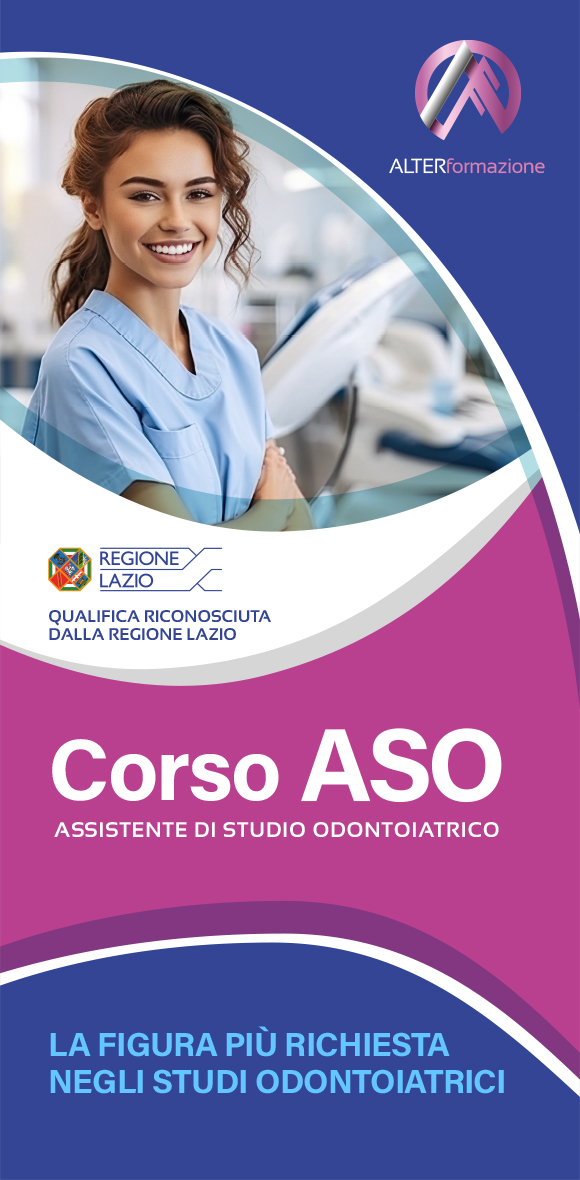Ogni città rappresenta un insieme di spazi che si intrecciano e convivono in equilibrio. Ci sono luoghi in cui si abita, altri in cui si lavora, altri ancora dove si compra, si studia o si trascorre il tempo libero.
Dietro questa organizzazione dinamica delle nostre attività quotidiane si nasconde una regola precisa, scritta nei piani regolatori e nei titoli edilizi: la destinazione d’uso urbanistica degli immobili. È un concetto che può sembrare esclusivamente confinato nel linguaggio dei tecnici e degli uffici comunali, ma in realtà riguarda la vita di tutti. La destinazione d’uso decide come può essere utilizzato un immobile e, quindi, influenza il modo in cui viviamo e abitiamo le città.
Secondo il D.P.R. 380 del 2001, il Testo Unico dell’Edilizia, la destinazione d’uso è la funzione per la quale un immobile è stato legittimato ad essere utilizzato. Ogni costruzione ha una “destinazione” scritta nei suoi titoli edilizi: è quella che ne determina la categoria urbanistica, le regole da rispettare e i limiti entro cui può evolvere.
Le destinazioni d’uso non sono tutte uguali: il legislatore le ha divise in cinque grandi categorie funzionali:
- Residenziale;
- Turistico-ricettiva;
- Produttiva e direzionale;
- Commerciale;
- Rurale.
La destinazione d’uso residenziale riguarda gli edifici destinati alla vita privata e familiare e richiede standard tecnici differenti dall’uso produttivo e direzionale, che comprende invece fabbriche, laboratori, uffici e studi professionali.
Definire la destinazione d’uso non è, pertanto, un dettaglio burocratico: è la chiave che determina cosa si può fare e cosa non si può fare in un immobile. Un’abitazione, per esempio, non può diventare automaticamente un ristorante, e una fabbrica non può essere trasformata in un loft residenziale senza le necessarie autorizzazioni. Il motivo è che ogni destinazione d’uso comporta un diverso carico urbanistico, ossia quante persone vi si sposteranno, quante auto circoleranno, quanto varierà la domanda di servizi pubblici, parcheggi, trasporti, scuole o rete fognaria. Per questo ogni cambiamento di destinazione va valutato con attenzione: il territorio deve essere in grado di sostenere quel nuovo carico senza alterare gli equilibri urbani.
Un edificio residenziale, ad esempio, genera un tipo di traffico e di consumo di servizi diverso rispetto ad un’attività sanitaria o un negozio.
Esistono però vincoli e limitazioni che possono impedire del tutto un cambio di destinazione d’uso, dettati dal piano regolatore comunale o dalle norme di tutela del paesaggio e del patrimonio storico, che servono a evitare che le trasformazioni snaturino l’identità dei luoghi. Nei centri storici, ad esempio, le regole sono spesso molto più restrittive. Qui la destinazione d’uso non è solo una questione di funzionalità, ma di conservazione culturale e sociale. Cambiare l’uso di un edificio può voler dire alterare l’equilibrio di un quartiere, la sua vocazione, la sua vita quotidiana.
Un caso concreto può servire a chiarire bene questa dinamica. Ipotizziamo di voler trasformare un’abitazione in uno studio professionale per attività sanitaria di un edificio che si trova a Roma nel centro storico. Il piano regolatore della città di Roma, forse il più complesso di tutta Italia, disciplina regole molto precise che mirano a conservare le funzioni originarie e la composizione abitativa dei palazzi storici, evitando l’inserimento di nuove destinazioni d’uso che potrebbero alterare la natura del contesto urbano. Il cambio di destinazione da residenziale a direzionale-sanitario non è sempre ammesso, proprio per questo motivo: il piano urbanistico locale tutela la permanenza della funzione abitativa, ritenendola parte integrante della struttura sociale del centro storico.
Il D.P.R. 380/2001 stabilisce le regole generali valide in tutto il Paese, ma la loro applicazione varia da Comune a Comune. Ogni città, attraverso il proprio piano regolatore e i regolamenti edilizi, adatta queste norme alle proprie caratteristiche e ai propri obiettivi.
Così, un Comune costiero potrà incoraggiare i cambi d’uso verso il turistico-ricettivo per sviluppare l’economia locale, mentre un centro storico potrà imporre limiti severi per difendere la residenza stabile e l’identità dei quartieri.
Le destinazioni d’uso non sono solo un tecnicismo: sono lo strumento con cui si bilancia il diritto del singolo proprietario a trasformare e valorizzare il proprio immobile con l’interesse collettivo a conservare l’equilibrio e la vivibilità dei luoghi.
Ogni attività sanitaria, che si tratti di uno studio professionale o di una struttura più complessa, come un ambulatorio, deve sempre essere pensata in stretta coerenza con la destinazione d’uso urbanistica dell’immobile che la ospita. Prima di iniziare qualsiasi lavoro di adeguamento è indispensabile verificare se l’uso previsto sia compatibile con la destinazione vigente o se sia necessario un cambio di destinazione d’uso.
Questo passaggio, spesso percepito come un mero adempimento amministrativo, di cui si potrebbe anche fare a meno, ha in realtà implicazioni concrete e rilevanti: comporta la predisposizione di una pratica edilizia specifica, il pagamento di eventuali oneri comunali legati all’aumento del carico urbanistico e la variazione catastale dell’immobile, con conseguenti effetti anche sul piano fiscale e tributario.
In definitiva, l’attività sanitaria non può, in linea generale, essere esercitata all’interno di immobili con destinazione d’uso residenziale, salvo i casi in cui la normativa locale ne preveda l’ammissione o l’uso promiscuo in misura limitata.
Per questo destinazione d’uso e funzione sanitaria devono procedere di pari passo: solo una progettazione consapevole, che consideri fin dall’inizio i vincoli urbanistici e le procedure autorizzative, consente di coniugare il diritto a esercitare la professione con il rispetto delle regole che governano il territorio.
A cura di Fabio Rossi
Se ti è piaciuto l’articolo condividilo con gli amici.
Se hai domande da porre scrivici a: redazione@sigmareview.it