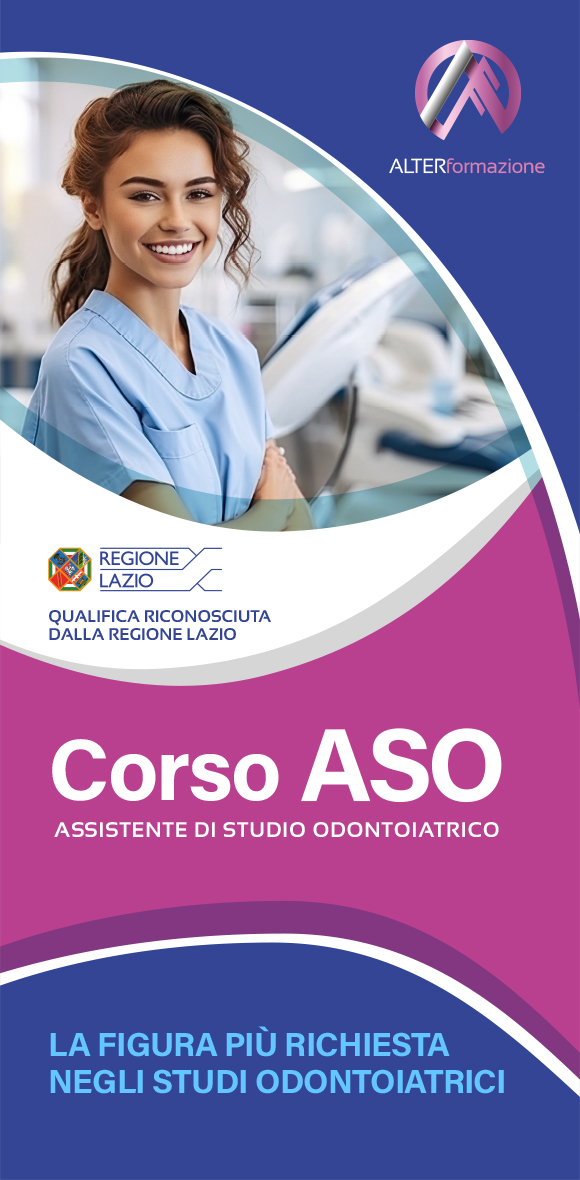Andrea Tuzio intervista il dottor Dario Paroletti, direttore dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e provincia.
Leggi il Sommario
Il direttore dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Dario Paroletti, conosce bene la macchina ordinistica: giurista, in servizio dal 1991, dirige oggi la più grande realtà ordinistica d’Europa, con oltre 47 mila iscritti. “Gli Ordini – sottolinea – non tutelano i professionisti, ma i cittadini, garantendo che chi esercita sia laureato, abilitato e iscritto all’albo.”
Negli anni, la struttura organizzativa si è notevolmente trasformata: dagli iniziali venti dipendenti negli anni Novanta, si è passati a oltre cinquanta, con uffici che gestiscono iscrizioni, personale, entrate, spese e affidamenti incarichi. Un sistema complesso, soggetto ai controlli della Corte dei Conti, che vive esclusivamente dei contributi degli iscritti e necessita di procedure digitali avanzate.
L’Ordine non si limita alla gestione amministrativa: rilascia pareri legali, promuove la formazione ECM e vigila sul comportamento dei professionisti tramite procedimenti disciplinari. Alla base c’è il codice deontologico, che regola il decoro e la correttezza della professione. Le sanzioni possono essere impugnate fino in Cassazione, ma spesso i procedimenti si intrecciano con quelli penali, generando ritardi nelle sentenze, aggravati dall’arretrato della Commissione Centrale.
Tra le sfide più significative, Paroletti ricorda la pandemia, quando lo Stato demandò agli Ordini il controllo sull’obbligo vaccinale dei sanitari: un compito imponente, che mise in luce il principio di sussidiarietà introdotto dalla legge Lorenzin del 2018.
Emblematico anche il caso di un noto personaggio pubblico, condannato per esercizio abusivo della professione grazie all’azione dell’Ordine: “Parlare di diagnosi e cure senza titolo è un reato”, ribadisce Paroletti.
Guardando avanti, il direttore auspica una riforma che separi indirizzo politico e gestione amministrativa: “Solo con un modello organizzativo che distingua chiaramente, come già avviene nello Stato, il livello politico e di indirizzo da quello tecnico-amministrativo gli Ordini potranno affrontare le sfide future.”
Leggi il testo completo dell’intervista
Giovedì 11 settembre 2025, sono circa le 15:00 del pomeriggio e siamo nella sala Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e provincia. Per la nostra prima intervista abbiamo con noi il Direttore dell’Ordine, il dottor Dario Paroletti.
AT – “Buonasera dottor Paroletti, ci fa una sua breve descrizione professionale, di cosa si occupa qui all’Ordine di Roma?”
DP – “Buonasera a lei e a tutti i lettori di Sigma Review. Le mie funzioni sono quelle di direttore dell’Ordine, ovvero un dirigente di prima fascia che ha responsabilità gestionali, amministrative e tecniche di un ente pubblico, così come semmai preciseremo meglio più tardi. Sono dirigente dell’Ordine dal lontano 1991, come vincitore di concorso pubblico, dopo una laurea in Giurisprudenza e una successiva abilitazione alla professione legale; ha avuto anche l’incarico di magistrato onorario presso la XIIIesima sezione del Tribunale di Roma.”
AT – “Dal 1991... quindi può vantare un bel po’ di esperienza e conoscenza storica dell’Ordine?”
DP – “Sì conosco bene le dinamiche dell’Ordine e, in generale, di tutti gli Ordini professionali. Gli Ordini non nascono, come potrebbe sembrare, per garantire in maniera esclusiva la professione. Per questo ci sono ovviamente enti di natura associativa e privatistica come, ad esempio, i sindacati. Gli Ordini, in qualità di enti pubblici, hanno come funzione preminente quella di garantire la corretta osservanza dell’esercizio della professione nei confronti degli utenti e quindi dei nostri cittadini.”
AT – “Come è cambiato l’Ordine dagli anni novanta, quando era appena arrivato, ad oggi?”
DP – “Sicuramente è cambiata la struttura organizzativa. Bisogna considerare sostanzialmente due componenti che caratterizzano la struttura di un Ordine professionale: una parte più propriamente politica, Consiglio Direttivo e Commissioni d’Albo, con cariche elettive che gestiscono l’Ordine da un punto di vista istituzionale e deontologico, e una struttura amministrativa composta dagli uffici che hanno la responsabilità della funzione gestionale, tra l’altro sempre più complessa perché si deve garantire il rispetto di tutte le leggi dello Stato. Giusto per citare un esempio, siamo soggetti ai controlli della Corte dei Conti per la verifica di tutte le voci di spesa dell’Ordine che, essendo un ente pubblico, se pur finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, deve garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie, assicurando la congruità delle spese e la legittimità dei propri atti amministrativi. Quando sono entrato negli anni Novanta c’erano una ventina di dipendenti, oggi siamo più di cinquanta, con una struttura organizzativa sempre più importante e complessa perché le funzioni dell’Ordine sono aumentate e quindi l’organo di gestione politica, cioè il Consiglio Direttivo, ha bisogno di un supporto sempre maggiore da parte degli uffici.”
AT – “Possiamo fare però un passo indietro e partire intanto nello spiegare che cos'è un Ordine Professionale e a che cosa serve?”
DP – “Gli Ordini delle professioni sanitarie, così come li conosciamo oggi, nascono nel 1946 con una legge specifica, un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, il n. 233 del 13 settembre 1946, che disciplina la tenuta dell’Albo dei medici-chirurghi (successivamente nel 1985 si aggiungerà l’albo degli Odontoiatri), e di altre professioni sanitarie, come i farmacisti, i veterinari etc. Sono passati parecchi anni ma la funzione principale è sempre la stessa, come dicevo prima, ovvero quella di garantire l’esercizio e il decoro delle professioni sanitarie, ma non in funzione della mera tutela degli iscritti, ma con il compito di garantire tutti i cittadini, in modo che costoro sappiano che il sanitario a cui si rivolgono per essere curati è laureato e abilitato all’esercizio della professione. Ogni volta che ci si rivolge ad un medico o ad un odontoiatra per una terapia piuttosto che per la diagnosi di una patologia, ogni cittadino può controllare sul nostro Albo se il medico o l’odontoiatra sono iscritti. Uno degli obblighi più importanti, infatti, dell’Ordine è la tenuta degli albi, che serve innanzitutto, attraverso la verifica dei titoli di laurea e di abilitazione, a garantire la legittimità dell’iscrizione all’Albo, scongiurando e contrastando il fenomeno dell’abusivismo medico ed odontoiatrico. L’Ordine ha poi altri compiti, come quello, appunto, di controllo dei propri iscritti attraverso il potere disciplinare: nell’organigramma è previsto un ufficio legale che supporta le Commissioni disciplinari nei procedimenti a carico degli iscritti. Un’altra funzione importante dell’Ordine, anche se di più recente attribuzione, è quella della formazione: gli Ordini devono verificare e promuovere la formazione dei propri iscritti, la cosiddetta Educazione Continua in Medicina, un sistema obbligatorio per i professionisti sanitari che, per tutelare e potenziare la loro preparazione e professionalità, assicura l’aggiornamento delle competenze attraverso l’acquisizione di crediti formativi (ECM).”
AT – “Ma tutto questo come si traduce nelle attività che quotidianamente vengono svolte?”
DP – “C’è tutta la gestione amministrativa che è divisa a livello organizzativo tra un settore che afferisce all’attività più propriamente istituzionale (il potere disciplinare, la tenuta dell’albo, la formazione etc.) e un astro settore di supporto e gestionale che afferisce alla struttura amministrativa degli uffici. L’Ordine per esercitare le funzioni di legge e quello che la legge prescrive deve avere del personale amministrativo di supporto: ad esempio nella pianta organica è previsto ufficio del personale che, in un ente pubblico, deve essere strutturato in quanto per essere assunti è necessario bandire un concorso pubblico con procedure abbastanza complesse e vincolate da leggi statali; poi c’è tutta la parte relativa agli approvvigionamenti di beni e servizi, attraverso vari affidamenti fornitori con procedure di evidenza pubblica. Tutti processi abbastanza complessi, in applicazione del Codice degli Appalti. Non da ultimo bisogna considerare anche un ufficio che gestisce la riscossione delle entrate, perché l’Ordine, come dicevamo, viene finanziato dai contributi degli iscritti. Non essendoci una contribuzione statale, è necessario un settore amministrativo che si occupi delle procedure di incasso della tassa annuale. Per quanto si cerchi di semplificarlo, l’apparato burocratico è sempre più complesso ed è necessario un sistema informatico piuttosto evoluto, con risorse non solo di hardware e software, ma con personale specializzato. Faccio un esempio, adesso l’Ordine può riscuotere i propri contributi, come tutti gli enti pubblici, attraverso il pago-PA, procedura analoga a quella del pagamento dele multe, e questo presuppone una struttura informatica molto complessa nella gestione di tutte le modalità operative.”
AT – “Ha fatto numerose volte riferimento alla <<complessità>> della struttura organizzativa e di gestione. Credo questo derivi anche dal numero di vostri iscritti: è vero quello che si sente spesso dire che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma sia il più grande d’Europa?”
DP – “Abbiamo più di 47.000 iscritti di cui circa 41.000 medici e 6.000 odontoiatri in tutta la provincia di Roma e siamo certamente l’Ordine più grande di Europa per numero di iscritti. I professionisti residenti o comunque tutti quelli che hanno un domicilio e lavorano nella capitale o in provincia devono essere iscritti al nostro Ordine. Gli Ordini sono divisi per province, sono 106 gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in tutta Italia. A Roma ha anche sede la Federazione Nazionale con funzioni di coordinamento e di indirizzo sugli Ordini provinciali.
Abbiamo creato un ufficio studi e contenzioso che, oltre a occuparsi di una parte relativa al contenzioso giudiziale e quindi ai rapporti con i nostri legali, svolge anche un’importante attività di studio e regolamentazione con pareri legali sull’attività sanitaria. Rilasciamo numerosi pareri legali relativi all’esercizio della professione ai nostri iscritti e a tutti i cittadini. Svolgiamo, anche attraverso i nostri consulenti, un’attività di assistenza pluridisciplinare.”
AT – “Parlando di procedimenti disciplinari non possiamo non parlare di codice deontologico. L’Ordine sanziona i propri iscritti soprattutto in base alle disposizioni del codice deontologico. In cosa consistono i cosiddetti illeciti di natura deontologica?”
DP – “Il codice deontologico è un codice di autoregolamentazione, deliberato dalla Federazione Nazionale e approvato dal Consiglio dell’Ordine, che racchiude una serie di norme che regolano il comportamento e il decoro della professione. Ha una rilevanza importante nell’ambito dei procedimenti disciplinari anche in relazione ai procedimenti penali a carico dei nostri iscritti. Nel momento in cui un medico o un odontoiatra vengono condannati ad es. per lesioni o omicidio colposo, tale condotta penalmente rilevante comporta anche l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’scritto all’Ordine per violazione del codice deontologico.
L’Ordine dei Medici ha infatti il compito di vigilare sul decoro e sulla correttezza della professione, mantenendo rapporti con la magistratura: quando l’Ordine viene a conoscenza di un procedimento penale a carico di un iscritto (anche nella fase delle indagini), acquisisce gli atti del procedimento. In caso di rinvio a giudizio, l’Ordine apre un fascicolo disciplinare, che viene però sospeso fino alla definizione del processo penale, per evitare decisioni discordanti. Di norma l’Ordine recepisce le valutazioni della magistratura, ma in alcuni casi, dopo un esame approfondito degli atti, può anche giungere ad una decisione non conforme alle valutazioni della Magistratura, non ravvisando illeciti deontologici.
Il procedimento disciplinare dell’Ordine dei Medici prevede più gradi di giudizio: contro una sanzione è possibile ricorrere in secondo grado alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (organo d’appello presso il Ministero della Salute) e in terzo grado anche in Cassazione. Le sanzioni più gravi, come la sospensione o la radiazione, restano sospese fino alla decisione della Commissione Centrale. Negli ultimi anni, però, questo organo ha accumulato un forte arretrato, con il rischio che professionisti radiati potessero continuare a esercitare in attesa della decisione. Per superare la criticità, il legislatore ha istituito una commissione “stralcio” incaricata di smaltire i procedimenti pendenti.”
AT – “Molto chiaro grazie. Cambiando ora completamente argomento, parliamo ovviamente sempre di Ordini professionali, ma vorrei un suo commento sulla famosa Legge Lorenzin del 2018, che aveva l'obiettivo di riformare gli ordini professionali. Ci dica intanto se c’è riuscita e che novità ha portato?”
DP – “Con la legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, la c.d. legge Lorenzin, si è compiuto un passaggio che, almeno sul piano formale, è stato considerato storico: gli Ordini professionali hanno cessato di essere qualificati come semplici enti ausiliari dello Stato per diventare enti sussidiari dello Stato. Un cambiamento che, a livello politico e mediatico, è stato molto enfatizzato, come se segnasse una rivoluzione copernicana nel rapporto tra lo Stato e gli Ordini delle professioni sanitarie.
In realtà, per chi come me vive quotidianamente la vita operativa dell’Ente, non ho ravvisato un cambiamento così radicale. Certo, un grande banco di prova è arrivato con la pandemia. Fu in quella circostanza che per la prima volta abbiamo esercitato in maniera tangibile il principio di sussidiarietà, ossia quando lo Stato demandò agli Ordini il compito di controllare il rispetto dell’obbligo vaccinale dei medici e degli odontoiatri. Una funzione tutt’altro che semplice. Si trattava infatti di verificare le certificazioni vaccinali di decine di migliaia di iscritti, identificare chi non risultava in regola, avviare i procedimenti di sospensione dall’albo, notificare i provvedimenti e trasmettere le informazioni alla Federazione Nazionale. Un lavoro importante, che metteva gli Ordini al centro di una responsabilità delicatissima, con effetti diretti sulla possibilità per un professionista di continuare a esercitare. Questa gestione di carattere straordinario generò inevitabilmente tensioni. Da un lato, le difficoltà organizzative degli Ordini, che non erano strutturati per affrontare un compito di quella portata. Dall’altro, il malcontento e i ricorsi da parte di quegli iscritti che contestavano le misure, con un conseguente aumento considerevole del contenzioso legale. Le assemblee degli iscritti, chiamate ad approvare i bilanci, divennero terreno di confronto acceso: il rischio di una bocciatura avrebbe portato al commissariamento dell’ente. Così, quella che a prima vista poteva sembrare una semplice modifica terminologica, da “ente ausiliario” a “ente sussidiario”, si è rivelata, nella pratica, una prova di maturità istituzionale. La pandemia ha mostrato chiaramente come lo Stato, in situazioni emergenziali, possa affidare agli Ordini compiti cruciali di controllo e regolamentazione, con tutte le responsabilità, ma anche le difficoltà, che ciò comporta.”
AT – “Sono davvero felice, perché con un esempio è riuscito a chiarire a me e, sono sicuro, anche ai nostri lettori, finalmente il principio di <<sussidiarietà>>. C’è però un altro termine che viene speso usato, per non dire abusato, richiamato sempre nella Legge Lorenzin, ossia, citando testualmente, <<rappresentanza esponenziale della professione>>. Ci illumina anche su questa locuzione?”
DP – “La definizione di ente esponenziale ha origini nei vecchi manuali di diritto amministrativo. Fu introdotta da un noto giurista il Prof. Massimo Severo Giannini, per descrivere quegli enti pubblici di natura associativa che rappresentano una categoria professionale. In questo senso, gli Ordini professionali sono considerati enti esponenziali: non semplici associazioni private, ma enti pubblici che incarnano e danno voce a una classe professionale nel suo complesso. È importante distinguerli dalle associazioni sindacali, che invece hanno natura privatistica. I sindacati tutelano interessi specifici delle diverse categorie (medici ospedalieri, medici di base, specialisti, liberi professionisti, universitari), operano attraverso la contrattazione collettiva e rappresentano direttamente i propri iscritti. Gli Ordini, invece, hanno una funzione più ampia: rappresentano la professione nel suo insieme, vigilano sul rispetto delle regole deontologiche e garantiscono il corretto esercizio della professione verso i cittadini.
Nella pratica, però, la distinzione non è sempre così netta. Le dinamiche elettorali degli Ordini, che si rinnovano ogni quattro anni, sono spesso influenzate dai sindacati: gruppi di iscritti legati alle varie sigle si organizzano per presentare liste e conquistare la maggioranza nelle Commissioni d’Albo e nei Consigli direttivi.
L’Ordine dei Medici e Odontoiatri, ad esempio, prevede due Commissioni distinte, quella dei medici e quella degli odontoiatri, ciascuna con compiti specifici, soprattutto in materia disciplinare e di valutazione delle parcelle professionali. Il Consiglio direttivo, composto da medici e odontoiatri, ha invece funzioni più generali di indirizzo politico amministrativo. I due organi lavorano in parallelo: da un lato la funzione di garanzia e disciplina delle professioni, dall’altro la direzione politica e amministrativa dell’Ordine.”
AT – “Ci avviamo alla fine della nostra piacevole e interessante chiacchierata. Sarebbero tanti gli argomenti da approfondire, magari verrò a trovarla di nuovo, se vorrà. Ci racconta giusto un aneddoto a cui è particolarmente legato nella sua lunga esperienza qui all’Ordine di Roma?”
DP – “Sono molto legato ad una recente iniziativa dell’Ordine tra le più significative, anche per il forte risalto mediatico che ha avuto. Si trattava di una vicenda delicata perché moltissimi iscritti segnalavano all’Ordine i comportamenti di un personaggio che, pur non essendo medico né tantomeno iscritto all’albo, comunicava pubblicamente di medicina e proponeva teorie, consigli e “cure” in programmi televisivi, libri ed eventi. L’Ordine ha deciso quindi di intervenire con fermezza, denunciandolo penalmente per esercizio abusivo della professione. Non è stato un percorso semplice: nella maggior parte dei casi, infatti, l’abusivismo professionale è evidente, si pensi all’odontotecnico che viene sorpreso “con le mani in bocca” al paziente. Con questo personaggio, invece, la difficoltà stava nel dimostrare che anche attraverso la comunicazione pubblica, trasmissioni TV, conferenze, libri e quindi senza avere un rapporto diretto con il paziente, stesse comunque compiendo atti riconducibili alla professione medica.
Durante la fase istruttoria ci fu un importante collaborazione con la Procura e alla fine il Tribunale di Roma ha accolto le nostre argomentazioni, riconoscendo che parlare di diagnosi, terapie e prescrivere regimi di cura senza alcun titolo di studio, equivale a esercizio abusivo della professione. La sentenza, molto articolata e di circa settanta pagine, ha condannato il soggetto in questione a una pena vicina al massimo previsto, oltre che al pagamento di una provvisionale e al risarcimento del danno.
Pur essendo probabile che la vicenda prosegua in appello, la pronuncia rappresenta un risultato importante: afferma con chiarezza che parlare di medicina come se si fosse medici, senza esserlo, costituisce comunque un abuso. È stata una vittoria non solo giuridica, ma anche a tutela della dignità della professione e della sicurezza dei cittadini.”
AT – “Nel ringraziarla ancora per il tempo che ci ha dedicato, ci lascia con un auspicio per il futuro che riguardi, ovviamente, l’attività degli Ordini professionali?”
DP – “Sono ormai passati ottant’anni dalla prima legge istitutiva sugli Ordini professionali e, nonostante le riforme intervenute, compresa quella promossa dalla c.d. legge Lorenzin, il modello normativo presenta ancora alcune criticità. Una delle più evidenti riguarda l’assetto gestionale degli Ordini. La legge, infatti, continua a immaginarli come enti pubblici governati quasi esclusivamente dagli organi eletti, cioè dai Consigli direttivi e dalle Commissioni, attribuendo loro la responsabilità diretta di attività complesse come iscrizioni, procedimenti disciplinari e soprattutto della gestione amministrativa. In realtà, gli Ordini di sono enti pubblici articolati in strutture complesse, sottoposte a controlli statali e chiamate a garantire il rispetto di normative sempre più specifiche: dal codice degli appalti alla normativa sulla trasparenza, sulla privacy, sui concorsi pubblici, fino alla programmazione e alla conoscenza dei sistemi informatici. Compiti che non possono realisticamente ricadere solo su professionisti sanitari eletti negli organi di governo, la cui formazione è specifica per la professione medica o odontoiatrica, ma non certo per gli aspetti amministrativi, giuridici o gestionali.
Per questo, ciò che si auspica per il futuro, anche in vista di una nuova legge delega in discussione, è un modello che distingua chiaramente, come già avviene nello Stato, il livello politico e di indirizzo (affidato agli organi eletti, come il Consiglio e il Presidente) da quello tecnico-amministrativo, che deve essere garantito da personale qualificato con competenze giuridiche, economiche, ingegneristiche e informatiche. Solo così sarà possibile assicurare la legittimità e l’efficacia dell’azione degli Ordini, rispondendo in maniera realistica alle esigenze di cittadini e professionisti.”
AT – “Grazie ancora dottor Dario Paroletti e buon lavoro!”
Se ti è piaciuto l’articolo condividilo con gli amici.
Se hai domande da porre scrivici a: redazione@sigmareview.it